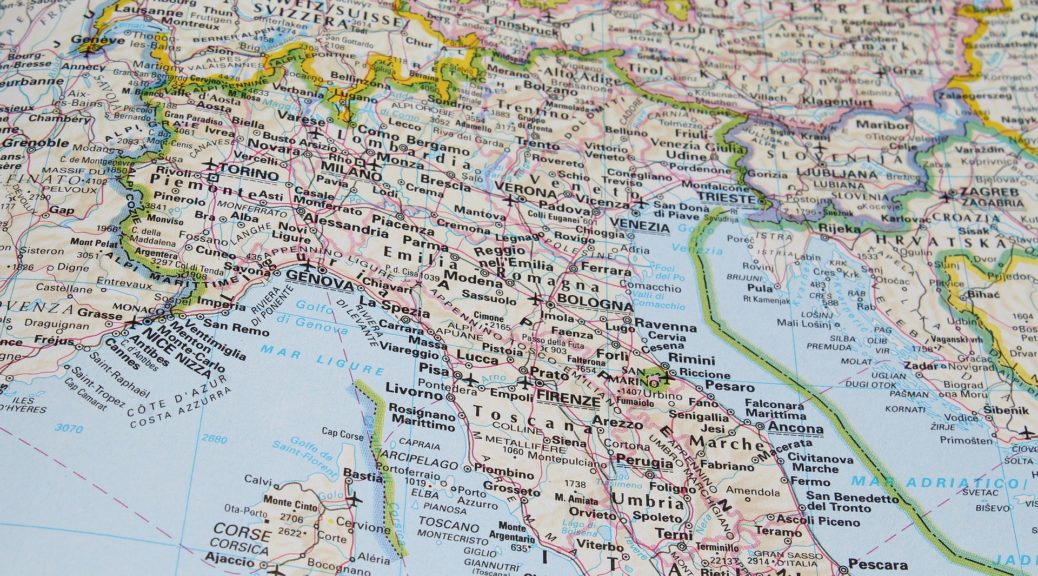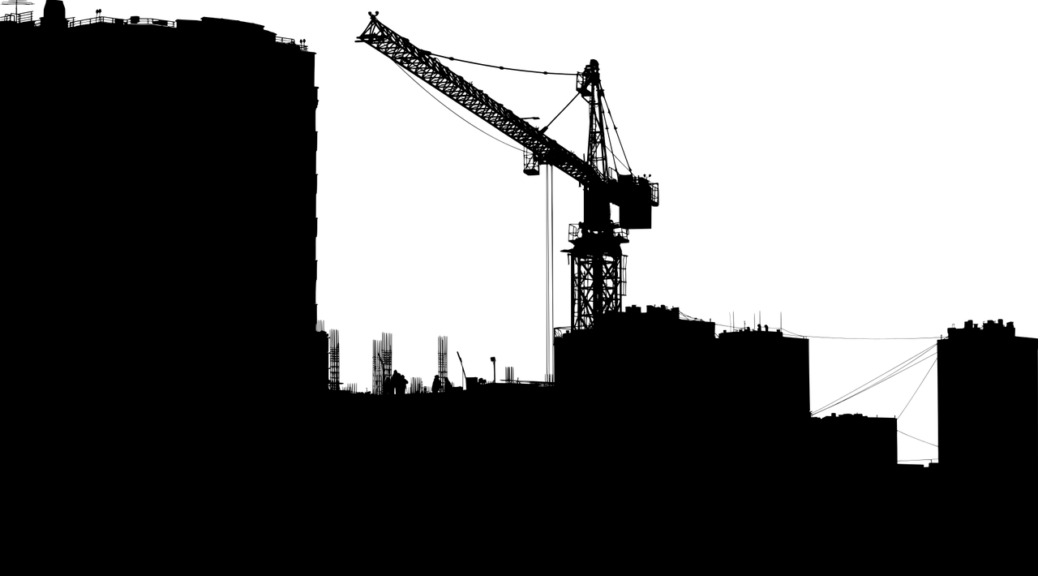Le ragioni del NO al taglio dei parlamentari.- di Massimo Villone Lo stenografico dell'audizione di Massimo Villone tenutasi alla Camera sulla proposta di legge di riforma elettorale.
Massimo Villone
Audizione per la proposta di legge C. 2329 Brescia, sul passaggio a un sistema elettorale proporzionale, e per la proposta di legge costituzionale C. 2238 Fornaro, che abolisce la base regionale per l’elezione del Senato
Camera dei deputati – Commissione Affari costituzionali – 27 maggio 2020
MASSIMO VILLONE, Professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II».
Grazie, presidente. Io vedo queste due proposte di legge come due proposte che, per una parte, prendono atto finalmente, magari con qualche ritardo, di quella che è la realtà del nostro sistema politico oggi, e, per l’altra, sono necessitate per la scelta, che è stata fatta, del taglio dei parlamentari. Sono proposte che, in qualche modo, accompagnano quella scelta, riducendone alcuni impatti palesemente nega-tivi. Voglio lasciare a verbale, perché sia chiaro, che personalmente considero quella scelta sbagliata (presiedo uno dei molti comitati per il «no»), quindi su que-sto non sono equidistante.Per quanto concerne la proposta C. 2329 Brescia, vedo essenzialmente in essa due punti focali. Il primo rappresenta quella che definirei la parte durevole della proposta, vale a dire il passaggio al sistema proporzionale. Si tratta di un pas-saggio di assoluto rilievo e sappiamo bene che sia in politica sia in dottrina ci sono due «chiese», sulla scelta del sistema elettorale: la «chiesa» del proporzionale e quella del maggioritario. Io da una ventina d’anni appartengo alla prima e, come è normale che accada, ci sono molti altri che invece si iscrivono con uguale fermezza alla seconda. Ricordo un articolo di D’Alimonte sul Sole 24 Ore dell’11 gennaio 2020, poco dopo la presentazione della proposta di legge del presidente Brescia. D’Alimonte si intende di sistema elettorale, ovviamente, ed era un articolo di duro attacco alla proposta. Il giornale lo intitolò: «Il proporzionale del Brescianellum pietra tombale sui governi stabili». Ricordo anche le valutazioni negative di perso-naggi di rilievo, come Prodi e Veltroni. Ci sono dei fan del maggioritario che non demordono. . Io credo, invece, che la proposta Brescia favorisca assai opportuna-mente questa scelta, perché non si può sostenere un’opzione maggioritaria quando il sistema non è più bipolare, come credo sia ormai vero per il nostro sistema e per un tempo non breve. Ritengo che ci sia un solo scenario in cui il sistema maggiori-tario – comunque configurato: di collegio, o con premi di maggioranza – funzioni
2 in modo ottimale, vale a dire quando ci sono due schieramenti che assorbono gran parte del voto del corpo elettorale, e che sono sostanzialmente equivalenti. Questo è lo scenario che ha reso il sistema britannico l’archetipo che è stato per molto tempo per una parte della nostra dottrina, la quale si è illusa che fosse questo si-stema elettorale a generare il bipolarismo. In Gran Bretagna tories e labour, per un tempo lungo, hanno assorbito tra l’80 e il 90 per cento del voto del corpo elettorale. Storicamente è accaduto questo. Il modello britannico ha cominciato a mostrare qualche crepa – che noi al di fuori non vedevamo, ma in Gran Bretagna se ne di-scuteva da tempo – quando questa realtà politica non è stata più vera, quando hanno cominciato a emergere soggetti politici che, pur avendo una consistente per-centuale del voto popolare, prendevano una manciata di rappresentanti alla Ca-mera dei Comuni. Poi negli ultimi anni abbiamo visto non voglio dire il collasso, ma il disgregarsi di quella che sembrava una certezza. Da noi è accaduto fonda-mentalmente questo: storicamente abbiamo avuto due partiti, la DC e il PCI, che hanno assorbito tra il 70 e l’80 per cento dei voti. Tuttavia uno di questi due partiti gli inglesi avrebbero detto che non era fit for government, non era ammesso al Go-verno, essendone escluso dalla nota conventio ad excludendum. Quindi il nostro sistema non poteva funzionare all’inglese, proprio per la diversa realtà politica. Quando questo assetto è venuto meno, con la caduta del muro di Berlino, e si è avuto l’ingresso nell’area del Governo del maggiore partito della sinistra del tempo, si è avuta l’illusione che il sistema elettorale potesse generare un bipolarismo all’in-glese. Questo è quel che è successo all’inizio degli anni Novanta. La scelta maggio-ritaria fu fatta nell’idea che così noi avremmo avuto un sistema all’inglese, con l’al-ternanza e tutte quelle belle cose di cui si parlava sempre. Solo che non ha funzio-nato. In realtà nel sistema britannico il bipolarismo non era un prodotto del sistema elettorale, ma uno spontaneo conformarsi della società. Nemmeno da noi il sistema elettorale ha creato il bipolarismo, anzi, ha ulteriormente frammentato il panorama politico, per dare alla fine un risultato non coerente con le aspettative di chi invece continuava a dire che la scelta del maggioritario ci avrebbe dato governabilità. Non abbiamo mai avuto governabilità. In più di vent’anni di maggioritario questa go-vernabilità non c’è mai stata, basta guardare proprio la storia quotidiana della Re-pubblica per rendersene conto. Ed è chiaro che in un sistema che non è bipolare, che non tende a essere bipolare, ma che si sta assestando, nel bene e nel male, su un assetto tripolare, il maggioritario non va bene. Non è più il piccolo vantaggio che consente a uno schieramento che è quasi equivalente all’altro di ottenere un margine numerico per governare, ma diventa una lotteria, perché significa pren-dere una minoranza, trasformarla in una fasulla maggioranza che non esiste nella
3 realtà del Paese e quindi distruggere la rappresentatività. Al tempo stesso, la gover-nabilità sarà comunque debole, perché si avrà un Governo che non rappresenta il Paese, anzi, ha contro di sé la prevalente parte del Paese. Questa è l’Italia che ab-biamo prodotto, l’Italia che è cresciuta nelle disuguaglianze, l’Italia dove si sono approfondite le fratture, le faglie territoriali, sociali e via dicendo.Oltre alla Gran Bretagna, anche altri sistemi – Francia, Spagna – tradizional-mente presi ad esempio per il maggioritario e la governabilità sono andati in crisi. Pochi giorni fa Macron ha perso la maggioranza assoluta che aveva nell’Assemblea nazionale perché gli si sta sfaldando in mano l’assemblaggio che ha messo insieme per vincere la partita elettorale. In Spagna Sánchez cerca affannosamente di tenere la zattera del suo Governo a galla. Non ho idea se ce la farà o meno, ma certo ha problemi, perché anche lì le fratture sono tali che il sistema elettorale non le can-cella, anzi, nel suo caso le esalta, perché è un sistema che premia il localismo (e se c’è un problema di localismo, lo troviamo proprio in Spagna).Quindi, credo che quella compiuta con la proposta di legge C. 2329 sia una scelta felice. Da parte mia spero vivamente che si riesca a mantenere questa scelta, non so poi se l’esito sarà in questo senso oppure no. Questa è la parte che io vedo durevole e proiettata verso il futuro. Invece, vedo un’altra parte sulla quale biso-gnerà ancora riflettere e suppongo che vi siano lavori in corso, ed è la parte delle liste. Per come l’ho letta io, siamo ancora alle liste bloccate. Non so se ho letto male, ma mi pare di capire, dalla ricostruzione che ho fatto di questa proposta, che l’esito è quello del voto alla lista, senza alcuna scelta del rappresentante. Ma se è così, se l’esito è quello di avere la totalità dei parlamentari scelti a lista bloccata, bisogna dire che l’incostituzionalità è certa, perché la Corte si è già pronunciata in tal senso con la sentenza n. 1 del 2014. Quindi, bisognerà necessariamente fare un passo avanti. Mi rendo conto che le preferenze sono un boccone indigesto. Non vedo come si possa evitare un meccanismo come il voto di preferenza, di cui cono-sciamo tutti i rischi, anche degenerativi di sistema, per così dire. Però se non c’ è la scelta del parlamentare vedo rischi peggiori. Porto anche la mia esperienza diretta: sono stato parlamentare per quattro legislature, tre con il «Mattarellum» e una con il «Porcellum», e la differenza tra i due sistemi elettorali era devastante proprio nel rapporto col territorio, con il corpo elettorale. L’ho vissuta in modo personale e immediato. Se non si ritrova questo collegamento, credo che nessun sistema elet-torale potrà andare lontano e, soprattutto, potrà contribuire a rafforzare l’istitu-zione Parlamento.
4 Comunque, condivido la scelta del proporzionale, rimanendo però consape-voli che la scelta del proporzionale da sola non assorbe tutto il profilo della rap-presentatività, non è da sola la risposta conclusiva. Qui entra in gioco il problema del taglio dei parlamentari, perché le due proposte effettivamente sono intercon-nesse. C’è un problema che viene citato anche nella relazione alla proposta C. 2238 Fornaro, quando si fa riferimento alla possibilità di collegi da un milione di abi-tanti. Effettivamente, un collegio da un milione di abitanti è un problema evidente, ma non c’è solo questo: dobbiamo capire che se non si scinde il Senato dalla base regionale, non usciamo da questa vicenda, perché avremmo nove regioni che eleg-gono da uno a cinque senatori, per cui qualunque sistema elettorale, anche il si-stema elettorale proporzionale, in regioni piccole e medio-piccole avrà un solo esito possibile: che in Senato arrivano due, forse tre forze politiche. Questo è inevitabile, perché è chiaro che anche se vi sono tre seggi, i due soggetti politici maggiori pre-varranno, in quanto il primo e il terzo seggio andranno al partito A e il secondo al partito B. Se vi sono quattro seggi, probabilmente toccherà a B e poi un’altra volta ad A. Con cinque seggi cominciamo ad avere probabilmente tre forze politiche rappresentate, ma non credo sia probabile averne quattro. Ciò significa che se tutto rimanesse secondo quelli che sono i sondaggi che oggi vediamo, in Senato avremmo soltanto due soggetti politici potenzialmente in grado di essere veramente nazio-nali: già il terzo e il quarto non lo sarebbero più, perché assenti in alcune regioni, pur essendo soggetti politici importanti. Se le cose rimangono come sono, come le vediamo il lunedì da Mentana, significa che in regioni con quattro o cinque senatori forze politiche come il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia – parliamo di forze politiche intorno al 15-16 per cento – non sarebbero rappresentate in regioni anche consistenti, in cui solo una o l’altra otterrebbero seggi perché sarebbero rappresen-tate soltanto la prima, la seconda e la terza forza politica, non la quarta. Ciò vuol dire che i soggetti politici veramente nazionali in Senato rimangono due, nella mi-gliore delle ipotesi, e che tutti gli altri soggetti politici sono una sommatoria di par-titi regionali o locali. Questo è devastante per il sistema politico nel suo insieme. Già abbiamo un Governo nazionale debole, ma è tale perché il sistema politico sul quale si fonda è debole e frammentato. Perché Boccia punta tutto sulla concerta-zione in Conferenza Stato-regioni e non usa i poteri sostitutivi che pure il Governo formalmente avrebbe? Perché evidentemente non ritiene di avere il peso politico e la forza per farlo. Ma questo perché? Perché i partiti che stanno a Roma sono fon-dati su una sommatoria di partiti locali e regionali. Questa rischia di diventare la caratteristica di fondo del sistema. Questo – più che il collegio di un milione di abitanti, che sarebbe un problema, ma si potrebbe affrontare – può essere un
5 problema che potrebbe portare questo Paese su un’orbita pericolosa, perché noi siamo già oggi un Paese malato di frammentazione, un Paese che tende a essere frantumato su questioni sulle quali invece dovrebbe essere unito. Se introduciamo un elemento di disgregazione ulteriore, credo che rischiamo come sistema Paese. Per tali motivi la proposta C. 2328 Fornaro mi sembra importante, soprattutto per questa parte. Poi si vedrà la delega al Governo, la riflessione ovviamente deve con-tinuare. Ma se noi pensiamo – come anche io, che pure, non essendo d’accordo, mi preparo a contrastarlo – che l’esito del referendum sia a favore del taglio del numero dei parlamentari, quello di ridefinire la base per il Senato scindendola dall’attuale formula della base regionale è un profilo che diventa essenziale.Quindi, si tratta di due proposte che, a mio avviso, pur richiedendo un com-pletamento perché il punto delle liste bloccate, a meno che io non abbia letto male, va corretto, per un verso prendono atto dell’attuale conformazione del nostro si-stema politico-istituzionale e, per un altro, sono necessitate dalle scelte che proba-bilmente ci troveremo ad affrontare.