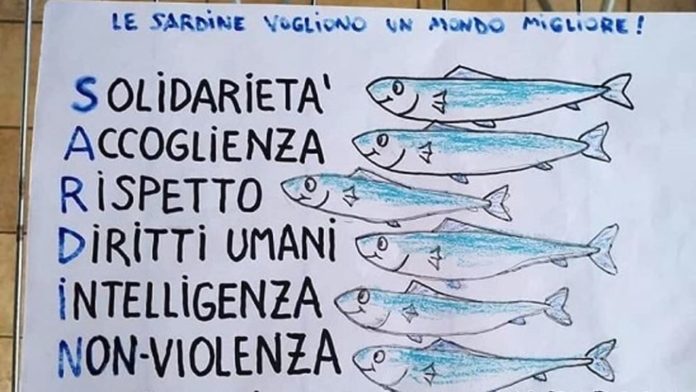La Calabria non è una terra ricca di materie prime, non ha grandi pianure vocate alla coltivazione intensiva, non ha un tessuto urbano ricco e di grande rilievo storico-artistico ed architettonico, non vi ha attecchito, com’è noto, l’industria, i suoi paesaggi sono ampiamente deturpati dalla cementificazione, ma continua, nonostante tutto, a possedere una grande quantità di siti archeologici di enorme rilievo: Sibari, Locri, Crotone, Vibo Valentia, Scolacium, Medma et cetera et cetera. Se avessimo governi nazionali e locali attenti alle esigenze della regione ci si potrebbe aspettare da loro un particolare impegno nella tutela e nella conservazione del Patrimonio archeologico calabrese, ma come dimostra l’operazione “Achei” del mai troppo lodato Nucleo Tutela Patrimonio dei Carabinieri, anche i beni che la Storia ha avuto il torto di lasciarci in eredità non sono affatto al sicuro, non sono stati, quasi per nulla, tutelati. Esisteva una associazione a delinquere che, come ha detto il tenente colonnello Valerio Marra, comandante del Nucleo TPC di Roma, “violentava la ricchezza culturale e storica del territorio” in maniera sistematica e continuativa da alcuni anni.
Dalle notizie fornite dagli inquirenti, che hanno condotto una indagine molto complessa ed approfondita, emerge un quadro davvero sconfortante riguardo agli scavi archeologici clandestini e distruttivi effettuati in questi ultimi anni. Colpisce non solo la piena conoscenza, da parte dei tombaroli, dei siti archeologici più ricchi, ma anche la competenza acquisita nel riconoscimento dei reperti archeologici e della precisa padronanza topografica, la “cartolina” che ricorre nelle intercettazioni, che hanno dei giacimenti archeologici calabresi. Questi tombaroli, questi ladri di memoria, si sono portati via un altro pezzo della nostra (anche della loro) storia, questa volta per sempre, questa volta senza alcuna possibilità di potervi porre rimedio.
Se le ricerche clandestine sono sempre distruttive dei contesti storici ed archeologici, i metodi usati da questa organizzazione di tombaroli suscitano, da una parte, la consueta e profonda indignazione, ma, dall’altra, sollevano più di un dubbio. Come è stato possibile che siano stati eseguite escavazioni con mezzi meccanici su siti archeologici vincolati o, perlomeno, notissimi alle autorità preposte alla tutela ed alla salvaguardia? Come è stato possibile che si siano fatti scavi e ricerche con sofisticatissimi metal detector e, addirittura, con droni dotati di sensori a raggi infrarossi, senza che se ne accorgesse nessuno, per anni? Come è stato possibile che abbiano potuto scorrazzare anche su siti che sappiamo esser dotati di videosorveglianza a distanza?
Le risposte si possono trovare nello stato comatoso in cui versano le Soprintendenze in tutto il territorio nazionale, ma, come si evince da questa vicenda, soprattutto in Calabria. Al netto dei problemi causati dalla Riforma Franceschini che ha separato la Tutela dalla Valorizzazione con la conseguente, iniqua, spartizione di mezzi e personale, si è verificata, negli ultimi anni, una drastica diminuzione dei finanziamenti al Mibac che pone l’Italia, anche se ci si continua a vantare di possedere il maggior numero di Beni culturali del mondo, agli ultimi posti in Europa per la spesa nel settore.
In Calabria la situazione è ancora più disastrosa perché, per esempio, le due Soprintendenze, quella di Cosenza e quella di Reggio Calabria, non hanno da molto tempo un Soprintendente, ma solo funzionari delegati dal Soprintendente ad interim che è, da mesi o da anni, il Direttore generale del Ministero. I funzionari archeologi destinati alla tutela e alla salvaguardia del territorio sono, in tutta la regione, meno di dieci e molti degli Uffici territoriali, come per esempio proprio quelli di Crotone e di Cirò, sono chiusi per mancanza di personale. L’assenza di “turn over” ha più che dimezzato i custodi in servizio che, peraltro, non sono più destinati, come accadeva un tempo, anche alla guardiania dei Parchi archeologici e dei siti vincolati nel territorio, ma sono, quasi tutti, esclusivamente adibiti alla custodia nei Musei e, peraltro, senza turni notturni. I pochi siti videosorvegliati potrebbero essere tenuti direttamente sotto controllo, dunque, solo di giorno, ma solo teoricamente perché, in realtà, nessun Museo o Ufficio territoriale dispone di un custode da destinare alla telesorveglianza dei siti.
La delinquenza organizzata, soprattutto nella regione che ha l’organizzazione mafiosa più pericolosa e ramificata del mondo, ha trovato grandi e facili opportunità di arricchirsi anche con il traffico internazionale dei reperti archeologici calabresi. Non sarebbe stato e non è, forse, necessario ed urgente cercare di prevenire questi reati con una adeguata tutela del nostro immenso ed inestimabile Patrimonio della cultura? Non sarebbe giusto, per esempio, nominare, subito, i due Soprintendenti di Cosenza e di Reggio? Non sarebbe conveniente assumere, al più presto, una quantità sufficiente di funzionari archeologi che preservino i nostri territori da questi veri e propri furti della memoria di un’intera popolazione? Non sarebbe utile assumere decine di altri custodi, restauratori e assistenti tecnici per conservare, al meglio, i nostri innumerevoli siti archeologici che potrebbero restituirci, una volta indagati e tutelati, la Storia plurimillenaria della nostra Regione? Non sarebbe stato opportuno investire grandi risorse economiche e sociali nella tutela e nella valorizzazione dei Beni culturali della Calabria, invece che dissiparli in inutili, costosissime e orrende Grandi Opere, come per esempio il cosiddetto “Megalotto” della Statale 106 che passerà, per l’appunto, anche sopra il sito di Sibari? Non sarebbe stato meglio impiegare tutti quei soldi nel raddoppio del tracciato ferroviario che avrebbe comportato, al contrario di una strada a quattro corsie, un danno minimo all’antico insediamento sibarita e, nello stesso tempo, non avrebbe avuto, forse, un minor consumo di suolo ed un minore impatto ambientale complessivo? Non sarebbe stato più giusto e più urgente, invece di investire 170 milioni di euro per una inutile metro di superficie, restaurare il Centro storico di Cosenza?
Potrei continuare ancora a lungo con questo tristo elenco, ma concludo affermando che sarebbe meglio meritarsele, le eredità storiche. Perché, queste eredità, non sono acquisite una volta per sempre, bisogna saperle tutelare, curare, nutrirle e noi italiani, in particolare noi calabresi, con tutta evidenza non ne siamo degni.
Quotidiano del Sud