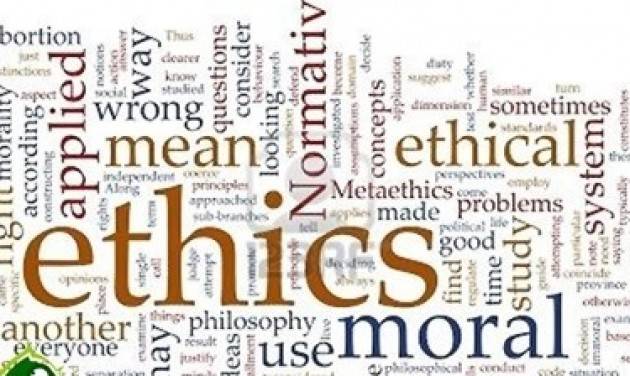
La gigantesca questione morale che, a sinistra, non si può più eludere.-di Piero Bevilacqua
Un segnale di quanto sia profondo e stratificato, il distacco del ceto politico dal comune sentire dei cittadini è la sottovalutazione del loro sentimento morale, della considerazione che una vasta platea di essi conserva per la coerenza delle idee, dell’attaccamento ai principi, ai valori del comportamento umano.
Vivendo in una vera e propria bolla, in una sorta di sopramondo in cui sembra che tutto sia lecito, i nostri uomini di partito, parlamentari, leader di varia taglia credono di superare indenni il giudizio dei cittadini se un giorno sostengono una tesi e un mese dopo il suo contrario, se militano in un partito e dopo un anno si trasferiscono in altro raggruppamento, se votano una legge considerata ingiusta e sbagliata per l’ambito di valore che orienta il campo elettorale che lo ha eletto. Immaginano che il loro cinismo travestito da Realpolitik sia lo stesso dei loro elettori.
Vero è che dopo decenni di devastazione dello spirito pubblico, dopo l’umiliazione storica del Parlamento italiano, che ha riconosciuto in una giovane in cerca di fortuna la nipote di Mubarak – per dirne una – il senso morale in Italia si è gravemente deteriorato. Tra politica ed etica pubblica si è aperto un evidente divorzio. La sensibilità per la dignità e l’onore che la Costituzione pretende dai parlamentari è stata in buona parte corrotta. E in tale opera di dissoluzione dei vincoli etici, che dovrebbero limitare la condotta pubblica degli uomini politici, una parte rilevante ha avuto anche la nostra stampa e soprattutto la televisione.
Io sono convinto che se non fosse stato per gli ostacoli frapposti dalla legge, per l’ergastolo e il 41 bis, i talk show della Tv pubblica e privata avrebbero fatto a gara per una intervista esclusiva a Totò Riina in prima serata. Non ignoro la potenza neoliberistica della competizione.
Resta da aggiungere per la verità che le varie leggi elettorali maggioritarie degli ultimi anni non hanno consentito ai cittadini elettori di scegliere i propri candidati, ancora oggi selezionati dalle segreterie dei partiti. Entrando nelle urne non hanno potuto premiare o sanzionare i loro rappresentanti in base alle scelte compiute. Nessuno può sapere, ad esempio, se gli elettori del Partito democratico avrebbero riconfermato Marco Minniti dopo che questi, con iniziativa di governo, ha affidato alla guardia costiera libica il compito di dare la caccia ai disperati che si avventurano nel Mediterraneo.
E tuttavia è esattamente allo sdegno morale dei cittadini più sensibili, insieme alle reiterate delusioni, ai tradimenti delle speranze e delle aspettative, che bisogna guardare per spiegare la crescita vertiginosa del non voto, l’altra faccia della luna dell’astensione.
Esiste ancora, soprattutto nell’ambito degli elettori di sinistra, una moltitudine di cittadini che hanno letteralmente abbandonato l’interesse per la politica a causa di alcune scelte dei propri leader. Lo hanno fatto in seguito al varo di alcune leggi, per scelte di politica interna o estera: atti che talora hanno creato ferite non rimarginabili nell’animo delle persone.
Credo che migliaia di italiani abbiano sperimentato lo stesso sentimento di rabbia, delusione, incredulità che ho sperimentato io nel 2006, quando Romano Prodi autorizzò il governo Usa ad allargare la base militare di Vicenza
In quel caso un governo, capeggiato da G.W. Bush, che aveva appena condotto una guerra di invasione contro l’Iraq, uccidendo centinaia di migliaia di iracheni (vedi collateral murder di Wikileaks ndr), che già possedeva centinaia di basi in tutto il mondo, Italia compresa, chiedeva di espandere la propria presenza militare nel nostro territorio. E il governo di centro-sinistra disse sì. Da allora i miei convincimenti sono stati sconvolti e io ho cominciato a guardare a quell’ambito politico come a un potenziale avversario dei ceti popolari del nostro Paese. La storia ha confermato la mia lettura di allora. Attraverso scelte meno gravi sul piano simbolico, ma simili, o più dirompenti sul piano sociale, la sinistra si è allontanata dai suoi tradizionali insediamenti operai e popolari perdendo il suo elettorato storico.
L’Italia, tuttavia, non dimentichiamolo, è un grande Paese. A dispetto degli arretramenti degli ultimi tempi e nonostante le vaste aree di corruzione e di malaffare che ne condizionano la vita, il cinismo di gran parte dei suoi gruppi dirigenti, possiede al suo interno formidabili anticorpi. Conserva presidi di democrazia e di senso morale nel mondo della cultura, dell’informazione, nella scuola, nel volontariato, in una vastissima area di cittadini comuni. Dunque, contrariamente a quanto immaginano gli stessi analisti che si occupano della politica italiana, il senso morale che ancora perdura in milioni di cittadini orienta anche il loro comportamento elettorale.
Esiste una vasta area di consenso potenziale tra milioni di italiani nei confronto delle forze politiche eticamente intransigenti. Si fanno illusioni i dirigenti di Sinistra italiana se credono di uscire indenni, agli occhi dei loro militanti ed elettori, dalla prova poco onorevole che hanno fornito nei giorni di apertura della campagna elettorale.
Che si voglia credere o no, una condotta intransigente sotto il profilo della fedeltà ai programmi annunciati, della coerenza di comportamento dei dirigenti, può favorire la crescita nel tempo di un partito come Unione Popolare, capeggiato da un ex magistrato come Luigi de Magistris.
Da qui potrebbe partire una inversione storica nel costume civile degli italiani: i partiti che tornano ad essere anche educatori, formatori di una consapevolezza di cittadinanza. Il ruolo che per alcuni decenni hanno svolto i partiti usciti dalla Resistenza, fondatori della Costituzione repubblicana.
da “Left” del 23 agosto 2022
Immagine: Francesco Lena





