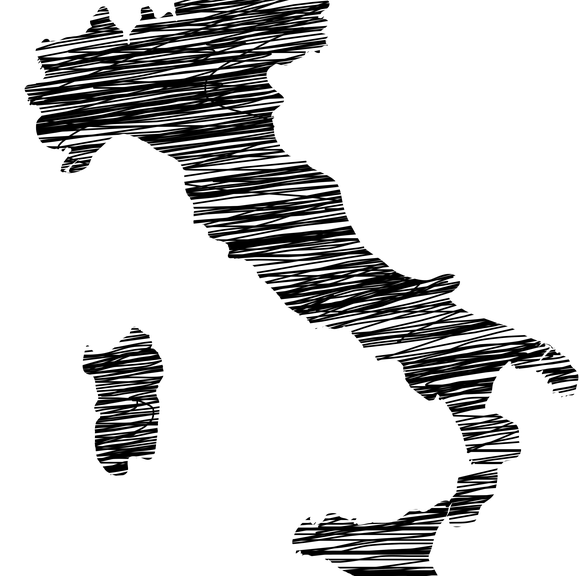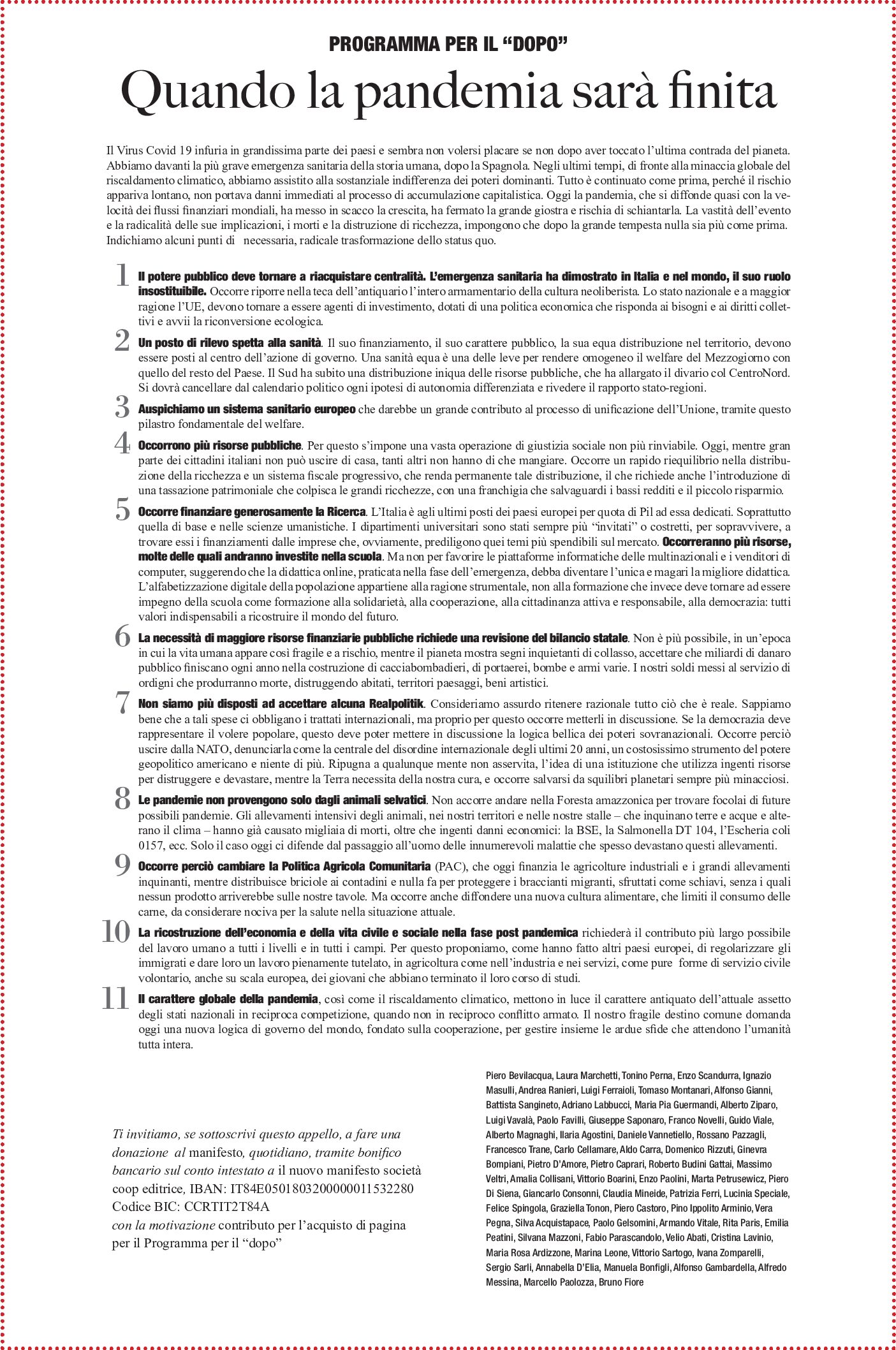Città come solidarietà.-di Giancarlo Consonni Non possiamo rischiare che tutto torni come prima
“I piani regolatori sono problemi di solidarietà umana, di coerente valutazione delle possibilità e degli ostacoli. Essi devono rappresentare la condanna delle ambizioni egoistiche, il ritorno nell’ora critica alla solidarietà e alla comprensione, la manifestazione di una volontà tesa verso scopi coerenti, costruttivi, creativi”1. Dopo tre quarti di secolo siamo a un’altra ora critica per l’umanità intera e ciò che Luigi Cosenza affermava nel 1944 dalle pagine de «La Rinascita» può essere riproposto pari pari in questi giorni tragici.
Per le coscienze vigili di questo nostro bellissimo e martoriato Paese, quelle affermazioni non hanno mai cessato di essere attuali. Non lo sono mai state, invece, per la stragrande parte degli amministratori della Cosa Pubblica. Il ruolo che essi si sono scelti (con il supporto compiacente dei “tecnici”) è stato quello di “facilitatori”: di creatori di opportunità per chi, disponendo di capitali, ha potuto fare delle operazioni immobiliari un affare redditizio come pochi altri. E questo in una impressionante continuità dal 1945 ad oggi, che fa impallidire le differenze di schieramento partitico; una continuità che a Milano si estende fino alle stesse politiche aggressive del ventennio fascista: lo spirito della Ricostruzione è stato ben presto tradito e negli anni ‘50 e ‘60 si è portato a termine ciò che il regime aveva iniziato.
Unica mitigazione: una politica della casa popolare che ha retto fino agli anni ’70. Ma questa apprezzabile opera di difesa dei lavoratori e dei meno abbienti è franata miseramente a partire dagli anni ‘80 quando si apriva il quindicennio di smobilitazione dei complessi industriali cresciuti nelle periferie urbane. Con la dissoluzione dell’industria urbana consumatasi nell’indifferenza di governo e opposizione veniva soffocato anche il lungo respiro delle politiche riformistiche sulla casa.
La questione non è tanto, e solo, l’impennarsi della rendita immobiliare (che avrebbe potuto e potrebbe essere arginata da adeguate politiche fiscali), ma il vuoto di idee, di visione strategica e di capacità di guidare i processi dimostrato da chi ha avuto e ha responsabilità di governo a tutti i livelli.
La politica non è stata in grado di elaborare un pensiero sulla convivenza civile e sulle interdipendenze fra questa e gli assetti insediativi. Ha lasciato che rendita e operatori immobiliari disegnassero a piacimento le configurazioni fisiche e funzionali degli insediamenti. Le bastava il “fare tanto per fare” (quand le bâtiment va…), con una irresponsabile soddisfazione per le entrate da oneri di urbanizzazione viste come il modo per rimpinguare i conti pubblici (irresponsabile perché, in assenza di bilanci credibili sul medio-lungo periodo, ha reso possibile un ingente travaso di denaro dal pubblico al privato). Così la questione del fare città, ovvero di come organizzare e attrezzare al meglio la convivenza civile, è stata totalmente disertata dalle politiche urbanistiche, come anche, in larga parte, dalle discipline che dovrebbero nutrirle in consapevolezza e strumenti.
Su quale sia la posta in gioco il cardinale Carlo Maria Martini ha detto l’essenziale nel 2002, nel suo discorso di congedo dalla città di Milano. Da laico voglio riportare alcuni passaggi: “[…] in forza della sua complessità localizzata, la città permette tutta una serie di relazioni condotte sotto lo sguardo e a misura di sguardo, e quindi esposte al ravvicinato controllo etico, e consente all’uomo di affinare tutte le sue capacità”2.
Martini aveva ben compreso l’uso strumentale della questione della sicurezza da parte degli imprenditori della paura e la causa prima di questa involuzione: “le nostre città […] non sono più sicure della propria identità e del proprio ruolo umanizzatore, e scambiano questa loro insicurezza di fondo con una insicurezza di importazione”. E indicava una possibile via: “La paura urbana si può vincere con un soprassalto di partecipazione cordiale, non di chiusure paurose; con un ritorno ad occupare attivamente il proprio territorio e ad occuparsi di esso; con un controllo sociale più serrato sugli spazi territoriali e ideali, non con la fuga e la recriminazione”.
Nella visione di Martini era ben presente quale ruolo fosse chiamata a svolgere l’urbanistica: “Per funzionare, la città abbisogna di gesti di dedizione, non di investimenti in separatezza”. Il suo sguardo era tanto acuto da restituire in sintesi quanto, nel contesto milanese e non solo, si era verificato nei vent’anni precedenti, ma anche da intravedere quanto si sarebbe verificato in seguito: “E così può nascere uno spirito di fuga dalla città, verso zone limitrofe protette, verso zone franche, per avere i vantaggi della città come luogo di scambi fruttuosi e l’eliminazione degli svantaggi di un contatto relazionale ingombrante. È allora la città destinata a disperdersi in un nuovo feudalesimo, compensato magari dalle impersonali relazioni mediatiche? È destinata a diventare un accostamento posticcio tra una city, identificata dal censo e dagli affari, e molte diversità a cui si concede di accamparsi in luoghi privilegiati o degradati, a seconda dei casi? E però se l’antidoto alla città difficile diventa una piccola città monolitica assediata dalle mille città diverse, la città perde il suo ruolo di identità-apertura e si originerà una faglia di insicurezza che metterà a repentaglio gli insiemi”.
In queste parole c’è, credo, un ritratto della Milano attuale, anche nella sua dimensione metropolitana. Ci dobbiamo arrendere? No. La città ambrosiana si troverà ad affrontare nei prossimi anni passaggi decisivi – il recupero degli ex scali ferroviari in primis – da cui dipenderà il suo futuro. Siamo a un bivio, e l’alternativa tra le due strade è quanto mai limpida: Milano è chiamata a decidere se incamminarsi verso una esasperazione della frantumazione o operare una svolta decisiva verso l’integrazione e la coesione sociale.
“La rinascita è un problema di uomini” scriveva Luigi Cosenza nell’articolo citato all’inizio. La rinascita, sarà possibile solo a partire da “un tessuto comune di valori” sembra fargli eco Carlo Maria Martini. Due affermazioni quanto mai veritiere dopo la tragedia del Coronavirus. Occorre “trovare le modalità di una traduzione civile partecipata e corretta delle emergenze umane del nostro tempo”, nella consapevolezza – sono sempre parole di Martini – che “la città evidenzia le differenze e stimola la politica al suo ruolo principe di promozione dei diversi, in modo particolare dei più umili fino a che possano raggiungere una uguaglianza sostanziale”.
1 Luigi Cosenza, Premesse per una rinascita dei centri urbani, in «La Rinascita», a. I, n. 2, luglio 1944, pp. 25-27
2 Carlo Maria Martini, Paure e speranze di una città, in «Città dell’uomo», a. XXV, marzo-aprile 2002, Appunti 2_2002, passim.
fonte:https://www.arcipelagomilano.org/archives/55723
Foto di Mirko Bozzato da Pixabay